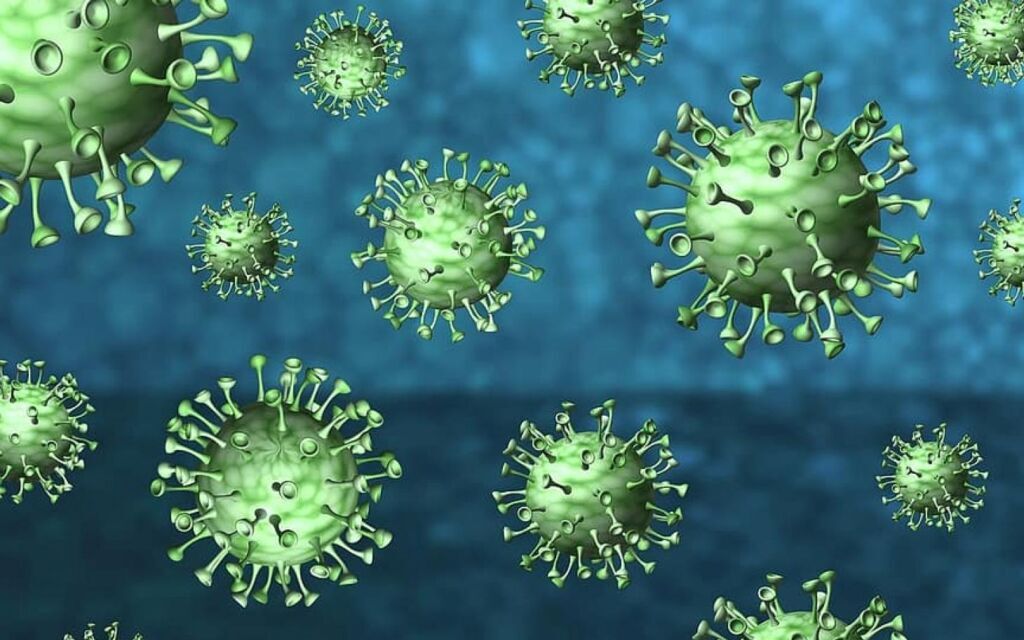Covid-19: cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali
Più si leggono notizie sulle ultime scoperte e applicazioni tecnologiche in campo biomedico più ci si rende conto di quanto la comunità scientifica sia in debito con le intuizioni di chi ha vissuto nel secolo scorso o, addirittura, in quello precedente.
Un’espressione spesso riportata sui giornali in queste ultime settimane è sicuramente anticorpo monoclonale.
Per i non addetti ai lavori, una coppia di parole alquanto lambiccata, che in effetti si riferisce a una biomolecola che nasce in laboratorio e che viene utilizzata in svariati campi, dalla medicina all’analisi delle acque.
L’anticorpo è una molecola biologica, in particolare una proteina naturale, che può essere prodotta dal sistema immunitario di organismi viventi in risposta all’invasione di virus o altri agenti patogeni.
Una delle più importanti conquiste scientifiche, ma certamente non recenti, è appunto aver saputo produrre in laboratorio la versione monoclonale di questa macromolecola. La quale è per natura capace di neutralizzare i virus legandosi direttamente a porzioni di essi, prevenendone dunque l’ingresso nelle cellule tramite i recettori di membrana e impedendo di fatto l’infezione.
Fin dal 1890 alcuni scienziati avevano scoperto l’esistenza di queste speciali proteine del plasma in grado, ad esempio, di bloccare il tetano o la difterite negli animali e che chiamarono antitossine.
In particolare Emil Adolf von Behring e Shibasaburo Kitasato scoprirono che piccole dosi delle succitate tossine erano in grado di stimolare la produzione di sostanze protettive nel siero degli animali. Inoltre, dimostrarono che il siero iniettato in animali non immuni aveva un un effetto profilattico e terapeutico contro l’infezione da tetano.
Anche alla TV sentiamo spesso discutere di questo stupefacente meccanismo protettivo peculiare dei vertebrati, in grado di produrre miliardi di differenti anticorpi grazie al sistema immunitario.
Degno di nota, ma per niente innovativo, è dunque il trattamento per curare i malati di Covid-19 con plasma proveniente da persone già guarite dall’infezione e che posseggono quindi nel sangue i naturali anticorpi specifici.
Ma facciamo un passo indietro e analizziamo la parola anticorpo e perché fu introdotta.
Bisogna tener ben presente che all’epoca delle prime scoperte le sofisticate tecniche della biologia molecolare e della spettroscopia per studiare la struttura di macromolecole dalla spiccata attività biologica non erano disponibili e che, quindi, queste sostanze non potevano essere identificate o caratterizzate in dettaglio.
Nel XIX secolo gli anticorpi rimanevano sostanze sfuggevoli di cui si conosceva però solo il potente effetto negli organismi viventi.
Tale circostanza rende ancora più significativi gli studi di questi pionieri, che si sforzavano di dare un nome quanto più appropriato a tali proteine, come appunto antitossine, precipitine, agglutinine o finanche reagine, a seconda della metodologia usata per separarle e isolarle dal siero.
Dobbiamo presumibilmente a Paul Ehrlich il nome di “Antikörper”, termine alquanto ambivalente perché si poteva riferire sia a un corpo che è capace di riconoscere un qualcosa, sia a un qualcosa che è capace di riconoscere un corpo.
Gli scienziati dell’epoca poi chiarirono che era giusta la seconda interpretazione, cioè che quel qualcosa presente nel siero era una macromolecola biologica (anticorpo) in grado di riconoscere un corpo (antigene) esogeno o endogeno.
Ben rappresenta visivamente questo meccanismo di azione il popolare schema serratura-chiave che è diventato uno dei capisaldi dell’immunologia.
Ma cosa significa monoclonale?
Nel 1984 gli scienziati Milstein e Köhler vincono il premio Nobel per la Medicina per aver scoperto già dal 1975 i principi che governano la produzione degli anticorpi monoclonali (mAb da monoclonal Antibody) cioè di anticorpi con nota e singola specificità antigenica.
L’importanza del breve rapporto pubblicato su Nature da Milstein e Köhler fu ampiamente sottovalutata, tant’è che esso fu relegato in una sezione diversa da quella dedicata dalla rivista alle scoperte di rilievo.
I due scienziati illustravano in un articolo di sole tre pagine come era possibile generare un ibridoma (cellula di fusione) capace di produrre grandi quantità di anticorpi monoclonali, sfruttando appunto l’immortalità offerta da una cellula tumorale (mieloma) fusa insieme a cloni individuali (da cui monoclonale) di linfociti B, cellule come sappiamo capaci di secernere anticorpi.
Nell’esperimento che è valso loro il Nobel l’innovazione risiede proprio nell’aver scoperto il metodo per produrre in gran quantità un anticorpo specifico per un singolo epitopo (epi topos, sito superficiale della sostanza estranea), laddove invece il sistema immunitario che viene esposto, ad esempio, al tossoide del tetano produce naturalmente una risposta anticorpale policlonale, in quanto gli anticorpi vengono prodotti da numerosi cloni di linfocita B.
Questa metodologia di produzione di anticorpi, che dal lontano 1975 si è ovviamente raffinata, viene sfruttata in campo biomedico e chimico da decenni anche a livello industriale.
Le applicazioni sono numerosissime. Basta evidenziare che nel campo delle analisi delle acque esistono dei kit che usano anticorpi monoclonali diretti contro le oocisti di Cryptosporidium e le cisti di Giardia per la determinazione della presenza di questi parassiti.
In campo medico esistono da anni anticorpi monoclonali approvati per la terapia di vari tumori capaci di legarsi ai recettori del fattore di crescita epidermico, recettori sovraregolati nelle cellule maligne. Le possibilità di utilizzo sono dunque innumerevoli.
Grande enfasi, giustamente, è stata data nelle scorse settimane (vedi la cura Trump) all’uso degli anticorpi monoclonali nel trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2, virus che provoca la Covid-19.
I vantaggi che offre questa terapia che “salta” la necessità dell’immunizzazione (ed è davvero una terapia in quanto è curativa) sono indubbi: gli anticorpi somministrati con un’iniezione, proprio per la loro specificità (meccanismo serratura-chiave), neutralizzano i virus e impediscono ad essi di entrare nelle cellule attraverso i recettori naturalmente presenti sulle cellule umane.
Bisogna sottolineare che mentre i vaccini stimolano la produzione di anticorpi e inducono nell’uomo una risposta immunitaria che in generale può durare a lungo, cioè anche anni, gli anticorpi prodotti e moltiplicati in laboratorio con la tecnica dell’ibridoma (a partire dagli anticorpi selezionati in alcuni pazienti malati e poi guariti) durano nell’organismo solo pochi mesi e richiedono quindi più iniezioni con cadenza regolare.
Per quanto riguarda i vaccini contro la Covid-19 (abbreviazione di coronavirus disease 2019 ), come pure per gli anticorpi monoclonali che mirano a neutralizzare il relativo virus, non abbiamo nessuno studio che abbia completato la fase tre, anche se spesso si sentono annunciare i trionfali risultati nei vari talk-show o twitter da questo o quel dirigente di qualche multinazionale del farmaco che sbandierano nientemeno che una forte (alleluia) risposta immunitaria al vaccino finanche negli anziani.
La risposta immunitaria è ovviamente un requisito essenziale ma non automaticamente e predittivamente correlabile con l’efficacia clinica che deve essere analizzata necessariamente e rigorosamente negli studi clinici e che nel caso dei vaccini possono durare anche 15 anni.
Allo stato attuale dunque non sappiamo molto sull’efficacia clinica né dei vaccini contro la Covid-19 né sull’efficacia clinica degli anticorpi monoclonali.
Costituiscono certamente degli strumenti utili a debellare la pandemia da SARS-CoV-2 con tecnologie consolidate e non innovative.
Di nuovo, in effetti, c’è soltanto il virus.
Con l’umile scopo di riportare scoperte fatte fin dal XIX secolo e con l’intento di riequilibrare la loro valenza storiografica nel panorama delle recenti applicazioni tecnologiche, vorrei concludere con una considerazione del farmacologo de Jong risalente al 1964 a proposito del recettore:
“Una donna seducente ma sfuggevole”
Per la maggior parte dei moderni farmacologi il recettore è come una donna seducente ma sfuggevole. Lui le ha scritto tante lettere e alquanto spesso lei ha risposto.
Da queste risposte il farmacologo è riuscito a costruirsi una immagine di questa donna affascinante. Lui tuttavia non può in realtà affermare di averla mai vista anche se un giorno potrà forse dirlo.
Emerge con quanta prudenza e grazia gli scienziati del passato (che ovviamente non conoscevano ancora nulla sulla struttura del recettore) si avvicinavano alla conoscenza e osavano descrivere questa enigmatica proteina chiamata così proprio perché si sapeva soltanto che era capace di far recepire sostanze all’organismo.
Pionieri che ardevano nel fuoco del dubbio alla ricerca della verità scientifica, appalesando con orgoglio la difficoltà del percorso della ricerca.
Emerge invece oggi solo la sicumera con cui si tesse l’affabulazione scientifica relegando le comunicazioni delle “scoperte” a meri bisbigli che ci sussurrano predizioni confortanti.
Una peculiarità che caratterizza sempre più il fare scienza di oggi ma che potrebbe offrire conclusioni scientifiche, quelle vere, inaspettate.